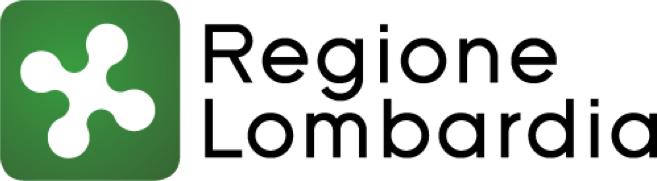-
Approfondimenti
“La mia battaglia per prevenire le morti improvvise di bambini e adolescenti”
Peter Schwartz, cardiologo giurato del Premio: “Basterebbero 6 milion per ECG a tutti i nuovi nati”.
di Redazione Open Innovation | 07/11/2017
La sua vita è cambiata un giorno di gennaio del 1971 quando, ricoverata in uno dei letti del Policlinico di Milano, incontra una bambina di nove anni la cui sorella era da poco morta improvvisamente a soli 18 anni. Da allora, 45 anni di studi hanno reso Peter J. Schwartz un’autorità a livello mondiale nello studio delle patologie cardiache di origine genetica. Già Presidente della Società Italiana di Cardiologia, il professor Schwartz è uno dei 14 top scientists chiamati da Regione Lombardia nella giuria del premio “Lombardia è ricerca”, la cui assegnazione al prof. Giacomo Rizzolatti è fissata per l’8 novembre al Teatro alla Scala. Molte collaborazioni all’estero - in USA, Europa, Sud Africa, Giappone -, dopo aver guidato per 20 anni la Cardiologia Universitaria al Policlinico S. Matteo di Pavia oggi Schwartz è Direttore del Centro per lo Studio e la Cura delle Aritmie Cardiache di Origine Genetica e del Laboratorio di Genetica Cardiovascolare dell’IRCCS Istituto Auxologico Italiano di Milano. È l’unico ricercatore europeo la cui attività scientifica è stata finanziata dai National Institutes of Health degli Stati Uniti per oltre quarant’anni, dal 1974 a oggi, senza soluzione di continuità.
Professore, lei è uno dei maggiori esperti della sindrome del QT lungo, malattia genetica che aumenta il rischio di arresto cardiaco e morte improvvisa. Quante persone ne soffrono?
“La sindrome del QT lungo – così chiamata dall’allungamento di un parametro specifico dell’elettrocardiogramma, l’intervallo QT - colpisce una persona ogni duemila, non è quindi una malattia rara, il problema è che si tratta di una patologia troppo spesso misconosciuta, nonostante la sua diagnosi non sia difficile. Anche oggi, troppi medici non la riconoscono e questo è grave, perché si tratta di una malattia che può essere fatale già al primo manifestarsi dei sintomi. Si tratta però di una malattia assolutamente curabile, e grazie a farmaci dai minimi effetti collaterali come i beta-bloccanti la mortalità oggi è scesa sotto l’1%. Nei casi più gravi sono altre due strategie terapeutiche. È dal 1973 che noi effettuiamo un intervento chirurgico che oggi viene utilizzato in tutto il mondo, ovvero il taglio dei nervi cardiaci di sinistra: un’operazione che dura 40-50 minuti, e che si esegue senza nemmeno aprire il torace. Quando questo non è sufficiente o il paziente o il paziente ha già avuto un arresto cardiaco, la terapia viene integrata con un defibrillatore impiantabile. Il 99% dei pazienti insomma può stare bene, se curato in modo adeguato: ciò rende inaccettabile il fatto che ancora troppi pazienti non vengano diagnosticati nonostante chiari sintomi. Questo è molto grave perché nella sindrome del QT lungo spesso il primo episodio è anche l’ultimo: infatti il 13% dei pazienti muore al primo manifestarsi dei sintomi. Si tratta di giovani che muoiono improvvisamente mentre fanno sport, dopo una forte emozione o uno spavento o rumori improvvisi. Da quando verso la metà degli anni ’80 questo alto rischio è stato compreso, è diventato imperativo riuscire a diagnosticare la malattia anche prima del manifestarsi dei sintomi”.
Come arrivare allora a diagnosi precoci, per evitare queste morti improvvise?
“Ogni medico di base dovrebbe sapere che in presenza di bambini o adolescenti con perdite improvvise di conoscenza in situazioni di stress fisico o emotivo è fondamentale eseguire un elettrocardiogramma, per misurare l’intervallo QT. A quel punto entra in gioco la genetica: da vent’anni abbiamo scoperto una serie di geni associati a questa sindrome, e il laboratorio che dirigo all’Istituto Auxologico vanta un successo dell’85% nell’individuazione delle alterazioni genetiche alla base della malattia. Questo ha un peso enorme, perché una volta identificata la mutazione specifica di un paziente con la sindrome del QT lungo, nel giro di due settimane possiamo verificarne la presenza o assenza nell’intera famiglia: controllo è indispensabile perché in circa il 30% dei pazienti con la mutazione genetica l’ECG è quasi normale e quindi in questi soggetti la malattia è difficilmente diagnosticabile. Tuttavia, queste persone sono a rischio di aritmie pericolose, soprattutto quando sono curate per altri disturbi con molte medicine di uso comune che prolungano l’intervallo QT (al nostro centro ogni anno distribuiamo a tutti i pazienti l’elenco aggiornato di questi farmaci)”.
Quanti sono i geni che causano la sindrome del QT lungo, finora?
“Diciassette, ma sono solo tre quelli principali presenti nel 90% dei pazienti. È importante sapere quale gene è coinvolto in un paziente, perché questo consente anche di identificare le situazioni di rischio maggiore. Nella forma più comune (LQT1), ad esempio, il rischio si associa a un’attivazione del sistema nervoso simpatico come avviene durante una corsa, nuotando o a seguito di un’emozione forte quale la paura. Nella seconda forma più diffusa (LQT2) il rischio si associa invece a rumori forti e improvvisi: tipicamente la sveglia o il suono del telefono all’alba. Nella terza forma (LQT3), meno comune, il rischio maggiore è durante il sonno. È anche grazie a queste nuove conoscenze che la mortalità è scesa ai livelli attuali; quando io ho iniziato a occuparmi di questa malattia il 21% dei ragazzi con la sindrome del QT lungo moriva entro un anno dalla prima sincope, e la mortalità arrivava addirittura al 50% entro 10 anni”.
Come è arrivato a occuparsi una patologia così insidiosa?
“Ero laureato da poco quando al Policlinico di Milano in cui lavoravo venne ricoverata una bambina di nove anni. Era svenuta varie volte, mentre correva o era spaventata, e la sorella maggiore era morta due mesi prima in diretta tv, mentre rispondeva a una domanda di Mike Buongiorno durante la trasmissione Rischiatutto. Sono riuscito a capire, con fatica e dopo oltre un mese, che era affetta dalla sindrome del QT lungo (allora sembrava l’undicesimo caso al mondo) e ho cominciato a studiare questa malattia, senza più fermarmi. Una scelta che ha cambiato la mia vita e quella della bambina, di cui sono stato poi testimone di nozze. Nel primo anno di terapia con i beta-bloccanti era stata meglio, ma aveva poi avuto un arresto cardiaco. A quel punto – era il 1973 – ho deciso di procedere con la denervazione cardiaca (mai fatta prima in Europa e con un solo caso negli USA) e da allora non ha mai più avuto problemi: sta bene e ci vediamo ogni anno”.
Questa sindrome è responsabile anche delle morte di molti neonati: lei ha indicato una strada precisa per la prevenzione di queste tragedie, quale?
“L’elettrocardiogramma neonatale di massa potrebbe essere cruciale in questo senso. Quando era ministro della Sanità, il prof. Umberto Veronesi (a cui è dedicata la giornata per la ricerca istituita per l’8 novembre, ndr) sulla base delle mie ricerche aveva fatto sapere di essere intenzionato a introdurre questo esame in tutta Italia, a carico del SSN, da eseguire nel primo mese di vita dei bambini. Abbiamo infatti dimostrato che il 10-15% delle cosiddette morti in culla o SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) è dovuto proprio alla sindrome del QT lungo: un ECG nel primo mese di vita permetterebbe di individuarla ed evitare sia queste morti precoci sia quelle che avvengono più avanti nella vita. Dal Ministero della Sanità avevamo avuto fondi per lo screening di circa 45 mila neonati, su cui abbiamo eseguito un ECG nella terza-quarta settimana di vita, seguito da un esame genetico nei bambini con tracciati sospetti per confermare la diagnosi emersa dal tracciato stesso. Abbiamo così dimostrato che una diagnosi precoce, che prelude a una prevenzione completa, è possibile e a costi irrisori: 12 euro per bambino”.
Nonostante questo, l’ECG neonatale non è mai stato adottato dal SSN?
“Purtroppo no, dopo l’avallo di Veronesi il governo cambiò, il successivo si disse interessato ma non se ne fece nulla. E così è stato in tutti gli anni seguenti, con altri esecutivi. Ci sono, è vero, una serie di ospedali italiani che continuano a eseguire l’ECG neonatale. Ma una sua diffusione a livello nazionale rimane il sogno della mia vita. Mi piacerebbe che la Lombardia fosse la prima regione a offrire questo strumento di prevenzione ai propri nati: si tratta di un esame non invasivo, in grado di intercettare anche altri tipi di cardiopatie pericolose e come dicevo poco costoso. La spesa per gli 82 mila nuovi nati ogni anno sul nostro territorio sarebbe di meno di un milione di euro, per quel che riguarda il livello nazionale l’ultima simulazione fatta nel 2009 prevedeva una spesa di 6 milioni di euro per 550 mila nuovi nati - allora la natalità era più alta -: una cifra pari a una parte su 17 mila della spesa sanitaria complessiva!”.
Quali sono le nuove frontiere del suo settore di ricerca?
“Stiamo lavorando molto con le cellule iPS, ovvero cellule staminali pluripotenti indotte. Grazie alle scoperte di uno scienziato giapponese, premiato per questo con il Nobel nel 2012, è ora possibile prelevare alcune cellule della pelle e trasformarle in cellule iPS. Noi abbiamo riprogrammato queste ultime come cellule cardiache, utilizzandole per prevedere la risposta dei pazienti a nuove terapie. Questa è indubbiamente una delle nuove frontiere della ricerca nel nostro settore. Faccio l’esempio del nostro ultimo lavoro, uscito su European Heart Journal un mese fa, in cui abbiamo preso queste cellule da cinque pazienti già colpiti da arresto cardiaco e portatori di una mutazione genica precisa, quindi le abbiamo trattate con un farmaco già utilizzato con successo per la cura della fibrosi cistica. Questo farmaco è in grado di correggere i difetti di ‘trafficking’ che impediscono alle proteine di raggiungere la membrana cellulare e di svolgere la propria funzione. Poiché nei pazienti con la variante comune LQT2 il meccanismo della malattia è proprio nel ‘trafficking’, abbiamo testato questo farmaco nelle cellule dei nostri pazienti osservando una risposta quasi incredibile, con una normalizzazione quasi completa. Ora stiamo chiedendo l’autorizzazione per poter valutare questo farmaco anche nei nostri pazienti.
Un altro fronte su cui ci muoviamo è quello di studiare i meccanismi di protezione spontanea presenti in pazienti portatori di mutazioni e malattia e che però non presentano alcun segno di malattia: su questo aspetto si concentrano le ricerche che da vent’anni conduco in Sud Africa, dove lavoro tre mesi ogni anno. Stiamo esplorando davvero la linea di confine con l’ignoto, ed è affascinante”.
Che prospettive vede invece più in generale per la ricerca scientifica, in Italia?
“Non c’è dubbio che vi siano delle aree e isole di eccellenza nella ricerca, soprattutto persone o gruppi con una lunga esperienza all’estero. Uno dei grandi limiti è che in molte istituzioni italiane permane un tipo di organizzazione nella quale, ad esempio, i titolari di cattedra firmano di prassi tutte le ricerche prodotte dai propri collaboratori anche se non vi hanno partecipato direttamente, cosa che non avviene assolutamente negli altri Paesi e che frena la crescita dei giovani ricercatori. La mia esperienza per fortuna è stata diversa, in quanto all’Università degli Studi di Milano ho avuto libertà assoluta, che però ho dovuto conquistarmi, facendo spesso esperimenti di notte o nel week-end. Altro punto fondamentale, i finanziamenti oltre a essere scarsi in Italia troppo spesso non seguono chiari criteri di merito: la mia fortuna è di essere stato finanziato ininterrottamente dal 1974 dagli Stati Uniti, dove la competizione è durissima ma corretta. Questo ha reso possibile il successo delle mie ricerche, anche perché il sistema di finanziamento americano a differenza di quello italiano e anche di quello europeo non è fiscale ma pragmatico, e lascia maggiore libertà di gestione dei fondi ottenuti: si può anche cambiare in corsa il contenuto dei progetti proposti, quello che conta per loro è che ci siano dei veri risultati e che questi siano rilevanti. Non importa dunque se per raggiungerli si prendono strade impreviste, diverse da quelle indicate magari cinque anni prima alla presentazione del progetto. Il nostro sistema invece rappresenta un grande limite alla creatività e dunque alla vera essenza della ricerca: le scoperte nascono spesso da intuizioni o da osservazioni non previste, all’inizio; se tutto fosse prevedibile dal primo giorno la ricerca scientifica si ridurrebbe a un’esecuzione pedissequa del progetto così come scritto, ma spesso ci si trova davanti a dati inattesi e sono questi a suggerire nuove linee di ricerca. C’è poi una questione di serietà e di fiducia: se negli USA si chiede una certa cifra per una ricerca, questa viene erogata in toto o quasi, magari si scende al 95% perché si ritiene che basti per il progetto presentato. In Italia capita di vedersi assegnare solo il 20% di quanto richiesto, perché altrimenti i fondi non basterebbero per tutti: non si opera quindi una vera selezione ma si distribuisce a pioggia, e per non scontentare nessuno si finisce col negare quello che serve elargendo cifre che non hanno alcuna correlazione con le spese reali. Questo è ciò che più mi irrita, ci vorrebbe il coraggio di fare delle scelte e di finanziare solo i progetti top. Se i fondi sono limitati vanno dati, nella misura adeguata, a chi ha dimostrato e dimostra di saper fare vera ricerca. Sono fondi pubblici e non si possono regalare un po’ a tutti. Si danno a chi li fa fruttare”.
In questo panorama, come si colloca il nuovo premio “Lombardia è ricerca”?
“Si tratta di un’iniziativa fantastica, pensata e organizzata bene, indica che Regione Lombardia ha davvero uno sguardo rivolto al futuro e centrato sulla ricerca”.
Vuoi essere sempre aggiornato?
Partecipa attivamente, accedi a Open Innovation