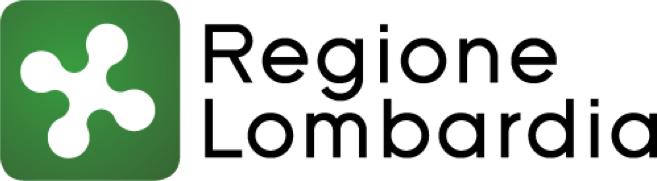-
Approfondimenti
Paracchi, CEO di Genenta start up dei record: “In Italia mancano Venture Capital per il biotech”
di Redazione Open Innovation | 06/10/2017
Diciassette milioni di euro di finanziamenti raccolti in meno di tre anni: decisamente non è passata inosservata Genenta Science, start-up fondata nel 2014 da Pierluigi Paracchi, Ospedale San Raffaele di Milano, dal direttore del SR-TIGET (Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica) Luigi Naldini e da Bernhard Gentner, ematologo del SR-TIGET. Un ufficio a Milano in via Olgettina e uno a New York, il Chief Medical Officer di stanza a Princeton, il responsabile della clinica medica con base in UK e la ricerca impiantata in Italia per un obiettivo ambizioso: trovare una cura anti cancro a largo spettro (cioè per diversi tipi di tumore) grazie a una terapia genica.
Il caso di questa start up evidenzia però in controluce i limiti della ricerca italiana, che pure avrebbe “enormi potenzialità”. Parola di Pierluigi Paracchi, 44 anni, Chairman e CEO di Genenta con alle spalle già diversi successi come Venture Capitalist nel settore biotech.
Paracchi, per inquadrare meglio la vostra storia partiamo dai numeri del Venture Capital in Italia, e da quelli dei Paesi con cui dobbiamo confrontarci: quali sono?
“Purtroppo restano imparagonabili. In Italia, considerando tutti i settori in cui opera il Venture Capital, non solo il biotech, si fa fatica a investire 200 milioni per anno. Negli Usa parliamo di cifre 25 volte maggiori. Ma se anche volessimo guardare a realtà con dimensioni e popolazioni raffrontabili alle nostre, la sproporzione appare evidente: la Spagna conta tre volte l’Italia, anche se ha meno abitanti e una ricerca di qualità inferiore, la Francia addirittura 2,7 miliardi, 13 volte l’Italia. La distanza è incredibile, e temo non sarà mai del tutto recuperabile: per farlo dovremmo crescere a una velocità maggiore degli altri Paesi, per molti anni, a oggi mi sembra impossibile”.
Veniamo a Genenta Science: la vostra scommessa?
“Genenta si occupa di sviluppare una terapia genica per la cura dei tumori. Usiamo un vettore virale, un derivato dell’Hiv e dunque del virus che genera l’Aids, quindi lo ‘smontiamo’ in laboratorio per renderlo inerte e lo carichiamo con un gene curativo che esprime una proteina antitumorale. Siamo in grado di modificare le cellule staminali nel sangue per riuscire a far esprimere questa proteina antitumorale a livello di microambiente del tumore, andando a riattivare il sistema immunitario e a combattere il tumore”.
A che punto siete nel percorso verso l’obiettivo?
“Ci troviamo ormai a un passo dalla sperimentazione clinica, che partirà nel 2018, dunque siamo in vista del primo traguardo che ci siamo posti alla fondazione, quando è iniziata l’attività di Genenta con la sperimentazione pre-clinica e la produzione del vettore virale di cui dicevo. Ora ci stiamo occupando di tutto quel che concerne gli aspetti regolatori: chiediamo dunque all’autorità europea di poter arrivare alla sperimentazione sull’uomo, sui primi pazienti”.
Come start up, la vostra è stata una partenza con il botto: chi ha creduto in voi?
“È così, abbiamo iniziato con un aumento di capitale sottoscritto per 10 milioni di euro da una serie di investitori privati coordinati da Mediobanca Private Banking, ovvero grandi famiglie imprenditoriali, ex imprenditori, top manager. A metà dello scorso settembre poi abbiamo fatto un secondo aumento di capitale per altri 7 milioni di euro: investitori privati, italiani svizzeri e inglesi. Tra questi ci sono la famiglia Rovati, fondatori dell’azienda farmaceutica Rottapharm venduta qualche anno fa e tra le famiglie più ricche al mondo, con un patrimonio personale di qualche miliardo; un brand noto al grande pubblico come quello dello stilista Salvatore Ferragamo, entrato con il suo family office; quindi un gruppo di business angels, il Club degli Investitori”.
Il vostro è un caso che ha fatto notizia. Ma qual è l’interesse dei capitali di rischio per il settore biomedicale, in Italia?
“Il panorama non è dei migliori, nel senso che non esiste a oggi un fondo di Venture Capital dedicato al biotech a livello nazionale, a differenza di quanto accade negli Usa e nel resto d’Europa dove gli investimenti sono enormi. Non ci sono VC italiani, interlocutori specializzati per finanziare solamente o prevalentemente terapie o farmaci e portarli a una fase sperimentale avanzata: al limite si investe in medical devices ma è altra storia. Si tratta di un limite drammatico, di una debolezza enorme per il sistema Paese perché in Italia in realtà c’è scienza di buona qualità, in parte di ottima qualità, ma senza un interlocutore finanziario attivo questa scienza rimane isolata”.
Come si supera questo limite?
“Dei tentativi sono già in atto. Vedi AurorA-TT ovvero il nuovissimo investitore appena partito che con gusto della sfida punta a lanciare fondi a sostegno del Technology Transfer bioteh. Sono venture consultant per AurorA-TT, società guidata da uno dei migliori manager italiani del settore Big Pharma a livello mondiale, Guido Guidi (già a capo del settore Pharma EU e di quello Oncologia EU di Novartis, ndr). AurorA-TT si candida a gestire 50 milioni di ITAtech, piattaforma nata dalla collaborazione tra Cassa depositi e prestiti e Fondo europeo per gli Investimenti, e altri 30 milioni per un fondo VC biotech nel Lazio dove sono presenti alcune università, istituti e centri di eccellenza”.
Lei dunque promuove la ricerca italiana. Molti lamentano la scarsità di fondi pubblici, che ne pensa?
“Il vero limite della ricerca italiana a mio giudizio è che le manca la cultura imprenditoriale, la propensione al rischio. Uno scienziato americano sa dialogare con operatori di Venture Capital e investitori mentre in Italia tra scienza e impresa manca un linguaggio comune. Il ricercatore dovrebbe insomma avere un minimo di conoscenza dei meccanismi di impresa, di come lanciare un prodotto. Il caso Genenta dimostra che mettendo insieme ottima scienza e capacità imprenditoriali i capitali arrivano. I finanziamenti non sono il punto di partenza, bensì quello di arrivo di una ricerca di qualità”.
Lei per Genenta ha seguito la parte imprenditoriale: come è arrivato al settore biotech, che pure come dicevamo non ha attirato molto l’attenzione degli investitori?
“Ho iniziato a occuparmi di Venture Capital nel 2002, a 29 anni, con un fondo generalista, Quantica SGR. Ho però capito presto che la qualità della ricerca nel campo delle Scienze della vita, della salute e del biotech era nettamente superiore: basti pensare, per rimanere al territorio lombardo e all’ambito di cui mi occupo, ad eccellenze come il San Raffaele, Humanitas, l’Istituto dei Tumori, che ospitano ricercatori in grado di competere a livello internazionale e in alcuni casi mondiale. Ho quindi investito in start up biotech, e fatto alcuni dei migliori investimenti italiani in questo settore, vedi EOS (Ethical Oncology Science), su cui abbiamo puntato nel 2009 e che poi abbiamo venduto a una società americana per oltre 450 milioni di dollari: più di dieci volte il valore dell’investimento iniziale”.
Insomma la scienza crea ricchezza. Un messaggio rivolto alle aziende, o alle istituzioni?
“I primi a muoversi credo debbano essere gli imprenditori, poi certo c’è una mentalità da acquisire che interessa anche le istituzioni a tutti i livelli. Il gap culturale però è imbarazzante: non a tutti in Italia è chiaro che l’industria del biotech è potente, ricca e in grado di creare moltissimi posti di lavoro, si parla di innovazione per reggere la competitività internazionale eppure non si guarda a uno dei settori in cui ricerca e innovazione sono strutturali. Per fare un altro esempio, si discute di Rcs-Corriere della Sera che in Borsa capitalizza 200 milioni quando una start-up del biotech come AAA – Advanced Accelerator Applications (fondata nel 2002 dal fisico italiano Stefano Buono ndr), dopo la quotazione al Nasdaq un anno fa, oggi vale 2,8 miliardi di dollari. E pochi ne parlano. Ora, molti investitori di AAA sono anche investitori di Genenta, segno che un’avanguardia di imprenditori non necessariamente del settore vede lì un’opportunità”.
Come si può rendere quest’avanguardia una scelta maggioritaria?
“Credo che la vera rivoluzione possa essere solo top-down: il sistema si potrà cambiare solo con casi di successo, per emulazione. Mi permetta di scherzare, ci vorrebbe l’effetto Alberto Tomba. Prima lo sci era uno sport per pochi: il fatto di avere un campione del genere lo ha reso uno sport di massa e ha di fatto creato un’industria. Successo chiama successo”.
Vuoi essere sempre aggiornato?
Partecipa attivamente, accedi a Open Innovation