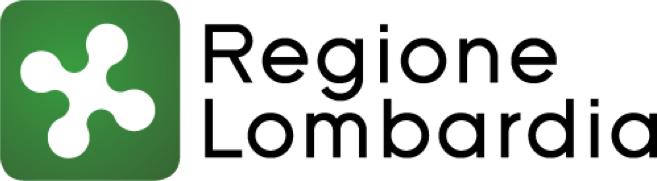In un’epoca in cui l’industria si evolve verso nuovi modelli produttivi, la trasformazione tecnologica non può prescindere dalla trasformazione culturale e organizzativa delle aziende. L’Industria 5.0 pone al centro le persone, richiede resilienza e promuove la sostenibilità. Ma come si traduce tutto questo nei contesti industriali reali, nei luoghi dove ogni giorno operatori, macchine e processi convivono e si trasformano? In che modo il design può contribuire in questo scenario?
È da questa domanda che ha preso forma l’evento “Design per l’industria manifatturiera: Tracce e racconti di sistemi di interazione e servizi per l’industria 5.0”, tenutosi il 10 luglio presso la sede di UCIMU — Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili — e promosso da BSD Design.
L’iniziativa aveva l’obiettivo di aprire uno spazio di riflessione e confronto sul ruolo del design nei contesti industriali complessi, in un momento storico segnato da profonde trasformazioni. Trasformazioni che, tra automazione, intelligenza artificiale e nuove forme di collaborazione tra persone e macchine, chiedono al design di estendere il proprio campo d’azione: da disciplina di progetto a vero e proprio facilitatore, mediatore e catalizzatore.
Un design che osserva, interpreta e riorganizza e che si fa prossimo ai contesti operativi, e che dialoga con le persone, anche quando il collega è un robot.
Il design entra in fabbrica: tra cultura e interazione
Ad aprire l’evento, Angela Di Massa — Design Lead, BSD — ha tracciato il quadro attuale dell’interazione uomo-macchina nei contesti industriali. Un quadro fatto di contraddizioni (“funziona solo se lo usa Mario”), resistenze culturali (“l’abbiamo sempre fatto così”) e ingegnosità quotidiane (“ci arrangiamo”), ma anche di una domanda latente: come può il design portare valore dove l’esperienza digitale è ancora condizionata dai limiti fisici e organizzativi?
Nel paradigma 5.0, l’operatore torna ad essere protagonista: le sue competenze diventano l’elemento abilitante della tecnologia. Il design, in questo scenario, si configura come infrastruttura di relazione, capace di mettere in dialogo esigenze operative, vincoli tecnologici e bisogni umani. Una capacità che si esprime anche attraverso la progettazione di interfacce — tangibili, conversazionali, aumentate, remote — pensate non solo per funzionare, ma per essere comprese, utilizzate e accettate.
Quattro sfide industriali, quattro approcci progettuali
Ha seguito il racconto di quattro casi progettuali affrontati dal team BSD Design, ognuno legato a una sfida concreta dell’industria manifatturiera.
La prima riguarda la perdita di know-how causata dal ricambio generazionale: gli operatori esperti lasciano l’azienda portando con sé conoscenze non formalizzate, mentre i nuovi arrivati, più digitali ma meno esperti, incontrano difficoltà a orientarsi. La soluzione proposta è un toolkit in realtà estesa (XR) che rende accessibile e visibile procedure, informazioni, tips e contenuti formativi direttamente sulle macchine, favorendo l’apprendimento in contesti reali.
La seconda sfida riguarda l’adattabilità dell’HMI a contesti operativi dinamici: molte interfacce industriali, progettate per un uso statico, risultano inadatte alle esigenze di operatori in continuo movimento. In questi casi, l’intervento progettuale va oltre la semplice modifica dell’interfaccia, trasformando l’esperienza d’uso per renderla più coerente con i bisogni e i vincoli reali degli utenti.
Un terzo progetto ha utilizzato il design per promuovere comportamenti sostenibili, integrando suggerimenti contestuali nei software aziendali per supportare scelte più consapevoli nelle attività quotidiane. Un approccio che non impone comportamenti, ma li abilita, facilitando la consapevolezza e la responsabilità individuale.
Infine, è stato presentato un progetto di redesign sistemico di un’applicazione aziendale interna. Il lavoro ha coinvolto attivamente una moltitudine di stakeholder e clienti in un processo collaborativo e incrementale, con l’obiettivo di comprendere a fondo bisogni e criticità. Il redesign ha riguardato non solo l’interfaccia, ma l’intera architettura del servizio in un’ottica olistica e strategica, indagando innanzitutto i veri problemi da risolvere.
Quattro esempi che mostrano come il design possa essere uno strumento concreto e strategico per affrontare le sfide concrete che le trasformazioni dell’industria contemporanea portano con sé.
Quando il collega è un robot
Sara Muscolo, PhD in Design e collaboratrice BSD, ha raccontato un caso di progettazione in un contesto in cui la collaborazione tra operatore e robot avviene in prossimità fisica. Non basta che il robot sia sicuro: deve anche comunicare, segnalare, farsi capire.
Attraverso osservazioni sul campo e test iterativi, sono stati sviluppati feedback luminosi capaci di veicolare messaggi chiari e interpretabili: colori, pattern e posizionamento delle luci studiati per aumentare la leggibilità delle azioni del robot e delle sue anomalie.
Un progetto che dimostra come il design possa agire anche nei dettagli più tecnici, abilitando una convivenza efficace e serena tra uomo e macchina.
Il design come interfaccia dell’innovazione
Alessandro Pollini, Managing Partner e Responsabile R&D di BSD Design ha offerto una riflessione articolata sul ruolo del design come strumento di mediazione tra tecnologia e cultura, tra sistemi complessi e pratiche quotidiane. Ha mostrato come la ricerca applicata e scientifica possa alimentare l’innovazione industriale, mappando casi studio e soluzioni che valorizzano la conoscenza degli operatori. Attraverso esempi concreti e riferimenti teorici, ha evidenziato come il design possa generare valore non solo estetico o funzionale, ma anche strategico, contribuendo a orientare i processi di innovazione all’interno delle organizzazioni. Il suo intervento ha posto l’accento sulla responsabilità progettuale nei contesti industriali, dove il design diventa catalizzatore di trasformazioni sostenibili e inclusive.
Dialoghi tra imprese e progetto
A chiudere la giornata, una tavola rotonda con i rappresentanti di alcune aziende del territorio — Stefania Balistreri per SDI Automazione, Francesco Acerbis per Step Automation, Davide Lucca per Rosa Ermando, Samuele Garofalo per Glue Labs — ha dato voce a esperienze eterogenee di collaborazione tra industria e design. Ogni azienda ha portato la propria prospettiva, raccontando esperienze di collaborazione con designer, processi di digitalizzazione, sviluppo di interfacce uomo-macchina e soluzioni di automazione avanzata. Il dialogo ha messo in luce il valore del design come strumento strategico per la competitività, sottolineando l’importanza di un approccio multidisciplinare, dell’ascolto reciproco tra progettisti e imprese e del coinvolgimento di tutti gli stakeholder nelle fasi di progetto. Tra i temi più ricorrenti, è emersa tuttavia anche una criticità trasversale: la resistenza interna al cambiamento, sia a livello culturale sia da parte degli utenti finali, che spesso ostacola l’adozione di soluzioni innovative e richiede un lavoro di accompagnamento e mediazione progettuale.
Verso un design industriale sistemico e consapevole
Dai casi condivisi emerge una traiettoria chiara: il design per l’industria non può più essere solo un esercizio formale o funzionale. È chiamato ad agire come ponte tra saperi, come interprete dei bisogni e come facilitatore dell’innovazione, coniugando vision di business, tecnologia, efficienza produttiva e centralità delle persone.
In un contesto segnato da transizioni rapide, competenze in evoluzione e nuove responsabilità, il design può — e deve — contribuire a costruire sistemi più resilienti, sostenibili e human-centred.
Non per semplificare la complessità, ma per imparare a gestirla in modo consapevole, ottimizzando gli scenari produttivi di oggi e domani.